Donne “cattive” con le Donne: Rivalità Femminile e Maschilismo Interiorizzato
La crisi della cooperazione orizzontale
In un’epoca segnata da narrazioni di sorellanza, empowerment femminile e cooperazione tra donne, emerge ancora e con forza un dato apparentemente dissonante, ma costante: molte donne riportano di sentirsi spesso giudicate, escluse o umiliate anche da alcune donne.
Ci sono amicizie femminili che degenerano in rivalità estetica o sentimentale, gruppi di lavoro al femminile segnati da silenzi, invidie e competizioni sotterranee, contesti educativi dove il sostegno reciproco si trasforma in bullismo relazionale: la ferita che una donna può infliggere a un’altra donna è spesso più profonda perché inattesa, “tradita”.
Il presente articolo si propone di indagare queste dinamiche dal punto di vista relazionale, interrogandosi su perché, ancora oggi, molte donne facciano fatica a cooperare tra loro, e perché la rivalità femminile si strutturi spesso in forme indirette, sottili, ma altamente distruttive.
L’ipotesi di fondo è che il patriarcato non abbia solo diviso le donne, ma abbia anche colonizzato l’immaginario femminile, inducendo alcune ad
interiorizzare modelli di potere simili a quelli che si criticano nel machismo (basati su competizione, esclusione, verticalità) al punto da riprodurli proprio in quelle relazioni che dovrebbero essere luogo di cura, riconoscimento e mutuo soccorso.
 Origini relazionali della diffidenza tra donne
Origini relazionali della diffidenza tra donne
Le prime relazioni significative di una bambina sono generalmente segnate dal legame con la madre e con figure femminili primarie. La qualità di questi legami costituisce il terreno affettivo e simbolico da cui si sviluppa la rappresentazione dell’“altra donna”. Quando la madre è percepita come giudicante, assente, ambivalente o ipercritica, è possibile che la figlia interiorizzi un modello di relazione femminile basato sul confronto, sulla disapprovazione e sull’insicurezza narcisistica. In questi casi, l’altra donna non è vissuta come alleata, ma come rischio speculare: un doppio minaccioso che mette a nudo la propria fragilità o inferiorità percepita.
Le prime relazioni significative di una bambina sono generalmente segnate dal legame con la madre e, indirettamente, dalla qualità della relazione col padre. Quando la madre è
giudicante, ambivalente o ipercritica e il padre è
assente, autoritario o inetto, si produce una frattura nel senso di sicurezza affettiva.
Se la madre tollera passivamente un padre svalutante o assente, la figlia può interiorizzare due modelli complementari:
- Il femminile come impotente o subordinato (madre che subisce senza reagire).
- Il maschile come potente, distante o punitivo, da cui dipende comunque il riconoscimento.
Questo genera una dinamica isterico-identitaria contraddittoria: la donna non cerca solo di affermarsi davanti alle altre donne, ma anche di ottenere un valore che, nella sua rappresentazione, resta
ancorato allo sguardo maschile. Da qui deriva la difficoltà a vivere altre donne come alleate: diventano
competitrici nello spazio del riconoscimento.

La società della prestazione come amplificatore
Quando questo terreno psichico incontra la logica sociale contemporanea implicitamente imposta — che
premia la performance, l’immagine e la vittoria — la rivalità si cronicizza e si trasforma in uno strumento identitario:
“Se tu vinci, io perdo”.
Il risultato?
Sororità fragili e alleanze opportunistico-intermittenti.
A ciò si somma la trasmissione intergenerazionale di dettami culturali impliciti: la scarsità simbolica del valore femminile. Per secoli, le donne non sono state riconosciute come soggetti autonomi,
ma come oggetti di scelta e valorizzazione maschile. Il principio di scarsità — “ce n’è posto solo per una”, “ce n’è uno solo da conquistare” — ha reso la competizione una strategia quasi obbligata. Così, l’altra donna è diventata la nemica da superare, non la compagna con cui dividere il peso della marginalità.
Il maschilismo interiorizzato come struttura invisibile
Il maschilismo interiorizzato non è una semplice forma di disistima personale o di adesione consapevole ai valori patriarcali. È, piuttosto, una struttura relazionale introiettata, un codice emotivo e culturale che organizza le modalità con cui le donne si percepiscono tra loro, si rapportano al potere e riconoscono (o negano) il valore al femminile. Questo codice si nutre della svalutazione sistemica dell’identità femminile: essere donna è stato, per secoli, associato a fragilità, invidia, manipolazione, mancanza di forza logica e morale. In questo quadro, molte donne hanno appreso che, per essere riconosciute, devono prendere le distanze dalle altre donne e da ciò che simbolicamente le rappresenta: emotività, cura, corporeità, solidarietà orizzontale.
Questo tipo di interiorizzazione nega la possibilità anche all’uomo di sviluppare il suo carente lato femminile, ma paradossalmente nutre le isterizzazioni e le polarizzazioni femminilizzanti del maschile.
Il risultato è l’assunzione di una postura relazionale gerarchica e fallica, che si esprime attraverso la negazione della vulnerabilità o il suo utilizzo a fini vittimistico-manipolativi, il giudizio, il controllo, il narcisismo compensativo e la disconferma reciproca. L’altra donna viene osservata con uno sguardo maschile interiorizzato: se è bella, è una minaccia; se è fragile, è ridicola; se è autorevole, va delegittimata; se è amica, va testata. In questo schema, l’aggressività non è mai dichiarata, ma esercitata attraverso pratiche invisibili ma profondamente destabilizzanti: esclusione, silenzio, pettegolezzo, ironia corrosiva, ambiguità.
Tutto ciò non avviene per malvagità intrinseca, ma perché il patriarcato non ha solo represso le donne, ma anche gli uomini costruendo il modo in cui essi si osservano tra loro. In una cultura dove il valore è concesso dall’alto, dove la bellezza è un capitale da spendere, e dove la vulnerabilità è trattata come colpa, molte donne si ritrovano a competere non per desiderio, ma per sopravvivere.

L’aggressività relazionale femminile: palese o sottile, ma sempre insidiosa
A differenza dell’aggressività diretta, l’aggressività tra donne assume anche modalità indirette, relazionali, estetizzate. Si colpisce l’immagine, non il corpo; si agisce sul legame, non sull’oggetto; si mira all’esclusione, non allo scontro. Crick e Grotpeter (1995) hanno parlato di aggressività relazionale per descrivere quei comportamenti che danneggiano l’altro interferendo con le sue relazioni sociali: si parla alle spalle, si diffonde una voce, si crea un clima ambiguo, si mette in dubbio la credibilità o l’autenticità dell’altra.
Nell’esperienza clinica, questo tipo di aggressività ha effetti devastanti.
Le donne che la subiscono riportano spesso sintomi depressivi, ansia sociale, senso di inadeguatezza e un’erosione profonda della fiducia nelle relazioni orizzontali. La sofferenza non è sempre riconosciuta, perché manca un’aggressione esplicita: non ci sono urla, insulti o gesti evidenti, ma una sottile corrente di delegittimazione che isola e ferisce.
L’aspetto più paradossale è che queste dinamiche spesso si attivano proprio nei contesti dichiaratamente femministi o cooperativi. In ambienti dove si predica la solidarietà tra donne, si assiste talvolta a fenomeni di “bullismo in rosa”, dove la norma gruppale è quella dell’omologazione: chi si distingue troppo, chi è troppo libera, troppo bella, troppo intelligente o troppo vulnerabile, viene silenziosamente esclusa. In questi casi, l’alleanza dichiarata tra donne si rivela una forma evoluta ma sofisticata di controllo reciproco, dove il femminismo diventa performance, ma non trasformazione reale.
Cultura dell’anti-vulnerabilità e ordine simbolico fallico
La cultura contemporanea è ancora profondamente impregnata di un ordine simbolico fallico, dove il valore è attribuito alla forza, al controllo, alla prestazione, la produttività e alla negazione della fragilità. In questo contesto, la vulnerabilità—una delle qualità più preziose per la costruzione del legame autentico—viene percepita come debolezza, e quindi da nascondere o disprezzare. Le donne, per essere riconosciute o sopravvivere in contesti competitivi, sono spesso indotte ad assumere comportamenti “maschili”: assertività spinta, disconnessione emotiva, leadership aggressiva.
Questa adesione difensiva a modelli fallici produce un paradosso tragico: nella ricerca di visibilità e valore, molte donne finiscono per replicare proprio quelle forme relazionali che le hanno storicamente escluse. L’identificazione con l’aggressore, in termini psicoanalitici, diventa la scorciatoia più immediata per proteggersi, ma al costo dell’empatia, della reciprocità e della possibilità di una cooperazione reale tra donne.
La competizione, così strutturata, non è più solo una questione di confronto, ma una vera e propria guerra silenziosa per il riconoscimento. In questo scenario, la solidarietà femminile appare come un’utopia fragile, e spesso, come una recita.

per approfondire:
Conseguenze cliniche e psicosociali
L’aggressività relazionale tra donne ha conseguenze profonde sia sul piano individuale che collettivo. A livello clinico, molte pazienti riferiscono esperienze precoci e ripetute di esclusione da parte di gruppi femminili, amicizie segnate dalla competizione o dall’ambiguità affettiva, e un senso generalizzato di sfiducia verso l’altra donna. Queste esperienze possono alimentare quadri di ansia sociale, depressione, ritiro relazionale, ma anche disturbi del comportamento alimentare e sintomatologie psicosomatiche.
Dal punto di vista sociale, la difficoltà delle donne a creare reti cooperative solide rappresenta un ostacolo strutturale alla loro affermazione. Quando il legame orizzontale è debole, quando l’altra donna è vista come nemica o rivale, viene meno quella base relazionale necessaria per costruire comunità, movimenti, trasformazioni collettive.
È proprio su questo piano che il maschilismo interiorizzato mostra la sua massima efficacia: impedire che le donne si riconoscano, si rafforzino e si proteggano a vicenda. E lo fa in modo subdolo, illudendole di star lavorando sulla loro indipendenza e auto-affermazione.
Verso una nuova alleanza tra donne?
Riconoscere la ferita non basta. Serve un lavoro profondo, culturale e psichico, che consenta alle donne di disinnescare i dispositivi relazionali appresi e di costruire nuove forme di alleanza. È necessario partire da un punto spesso trascurato: la possibilità di guardarsi tra donne senza giudizio, senza confronto, senza necessità di dominare.
Ciò implica una ridefinizione del valore stesso: non più centrato sulla competizione e sull’eccezionalità, ma sulla vulnerabilità condivisa, sull’ascolto, sulla legittimazione reciproca. Un processo di questo tipo può avvenire solo attraverso esperienze concrete di relazione trasformativa: gruppi terapeutici, reti di sostegno, pratiche educative relazionali che non si limitino alla teoria, ma generino esperienze emotive correttive.
La cura, in questo senso, diventa atto politico: un modo di restituire dignità al legame femminile, di creare spazi dove l’altra donna non sia minaccia, ma testimone.
 Conclusione
Conclusione
L’aggressività tra donne non è un destino biologico né un semplice effetto collaterale della socializzazione. È una costruzione complessa, che affonda le sue radici in dinamiche psichiche precoci, in modelli culturali profondamente sessisti e in una storia di oppressione sistemica.
Smontare questa struttura richiede lucidità teorica e coraggio affettivo. È necessario che le donne (e gli uomini) si guardino, si ascoltino e si parlino davvero. Che riconoscano il dolore che si sono inflitte e che scelgano, consapevolmente, di costruire un altro modo di stare insieme. Non per essere tutte uguali, ma per potersi finalmente permettere di essere diverse, libere e vive, senza dover per questo temere di essere ferite. Solo così il femminile potrà tornare ad abitare se stesso non come una maschera, ma come una potenza autentica.
Bibliografia
- Benjamin, J. (1988). *The Bonds of Love: Psychoanalysis, Feminism, and the Problem of Domination*. Pantheon Books.
- Gilligan, C. (1982). *In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development*. Harvard University Press.
- Guillaumin, C. (1992). *Sesso, razza e pratica del potere*. FrancoAngeli.
- Irigaray, L. (1977). *Questo sesso che non è un sesso*.
- Lorde, A. (1984). *Sister Outsider: Essays and Speeches*. Crossing Press.
- Melucci, A. (1994). *Identità e cultura nella società contemporanea*. Laterza.
- Mitchell, J. (1971). *Psychoanalysis and Feminism*. Penguin.
- Recalcati, M. (2011). *Cosa resta del padre? La paternità nell’epoca ipermoderna*. Raffaello Cortina Editore.
- Sassatelli, R. (2005). *Genere, corpo e soggettività*. Il Mulino.
- Simone de Beauvoir (1949). *Il secondo sesso*. Il Saggiatore.
- Smail, D. (2001). *The Origins of Modern Mind: A Cultural History of Brain, Emotion, and Self*. University of California Press.
- Wolf, N. (1990). *The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women*. HarperCollins.
- Young, I. M. (1990). *Throwing Like a Girl and Other Essays in Feminist Philosophy and Social Theory*. Indiana University Press.
 Origini relazionali della diffidenza tra donne
Le prime relazioni significative di una bambina sono generalmente segnate dal legame con la madre e con figure femminili primarie. La qualità di questi legami costituisce il terreno affettivo e simbolico da cui si sviluppa la rappresentazione dell’“altra donna”. Quando la madre è percepita come giudicante, assente, ambivalente o ipercritica, è possibile che la figlia interiorizzi un modello di relazione femminile basato sul confronto, sulla disapprovazione e sull’insicurezza narcisistica. In questi casi, l’altra donna non è vissuta come alleata, ma come rischio speculare: un doppio minaccioso che mette a nudo la propria fragilità o inferiorità percepita.
Le prime relazioni significative di una bambina sono generalmente segnate dal legame con la madre e, indirettamente, dalla qualità della relazione col padre. Quando la madre è giudicante, ambivalente o ipercritica e il padre è assente, autoritario o inetto, si produce una frattura nel senso di sicurezza affettiva.
Se la madre tollera passivamente un padre svalutante o assente, la figlia può interiorizzare due modelli complementari:
Origini relazionali della diffidenza tra donne
Le prime relazioni significative di una bambina sono generalmente segnate dal legame con la madre e con figure femminili primarie. La qualità di questi legami costituisce il terreno affettivo e simbolico da cui si sviluppa la rappresentazione dell’“altra donna”. Quando la madre è percepita come giudicante, assente, ambivalente o ipercritica, è possibile che la figlia interiorizzi un modello di relazione femminile basato sul confronto, sulla disapprovazione e sull’insicurezza narcisistica. In questi casi, l’altra donna non è vissuta come alleata, ma come rischio speculare: un doppio minaccioso che mette a nudo la propria fragilità o inferiorità percepita.
Le prime relazioni significative di una bambina sono generalmente segnate dal legame con la madre e, indirettamente, dalla qualità della relazione col padre. Quando la madre è giudicante, ambivalente o ipercritica e il padre è assente, autoritario o inetto, si produce una frattura nel senso di sicurezza affettiva.
Se la madre tollera passivamente un padre svalutante o assente, la figlia può interiorizzare due modelli complementari:
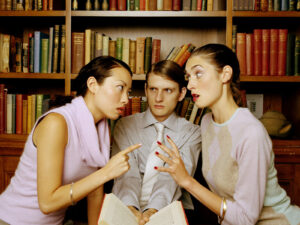

 per approfondire:
per approfondire:
 Conclusione
L’aggressività tra donne non è un destino biologico né un semplice effetto collaterale della socializzazione. È una costruzione complessa, che affonda le sue radici in dinamiche psichiche precoci, in modelli culturali profondamente sessisti e in una storia di oppressione sistemica.
Smontare questa struttura richiede lucidità teorica e coraggio affettivo. È necessario che le donne (e gli uomini) si guardino, si ascoltino e si parlino davvero. Che riconoscano il dolore che si sono inflitte e che scelgano, consapevolmente, di costruire un altro modo di stare insieme. Non per essere tutte uguali, ma per potersi finalmente permettere di essere diverse, libere e vive, senza dover per questo temere di essere ferite. Solo così il femminile potrà tornare ad abitare se stesso non come una maschera, ma come una potenza autentica.
Bibliografia
Conclusione
L’aggressività tra donne non è un destino biologico né un semplice effetto collaterale della socializzazione. È una costruzione complessa, che affonda le sue radici in dinamiche psichiche precoci, in modelli culturali profondamente sessisti e in una storia di oppressione sistemica.
Smontare questa struttura richiede lucidità teorica e coraggio affettivo. È necessario che le donne (e gli uomini) si guardino, si ascoltino e si parlino davvero. Che riconoscano il dolore che si sono inflitte e che scelgano, consapevolmente, di costruire un altro modo di stare insieme. Non per essere tutte uguali, ma per potersi finalmente permettere di essere diverse, libere e vive, senza dover per questo temere di essere ferite. Solo così il femminile potrà tornare ad abitare se stesso non come una maschera, ma come una potenza autentica.
Bibliografia





